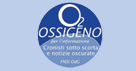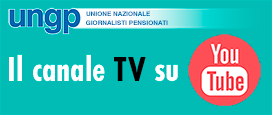11/12/2012
Consiglio nazionale dell’Ungp. La relazione del presidente Guido Bossa:
"Il nostro impegno per essere più credibili in una fase di crisi"
Il Consiglio nazionale si riunisce per la prima volta dopo il Congresso straordinario che l’11 giugno scorso ha chiuso positivamente una crisi che si era aperta al vertice della nostra Unione. La ritrovata unità dell’Unione ci ha consentito in primo luogo di partecipare pienamente alla vita del nostro sindacato in una fase complessa come quella che stiamo vivendo. Il nostro colloquio con i dirigenti della Federazione è costante: abbiamo partecipato, per la parte che ci compete, ai lavori di Giunta, alla riunione della Commissione contratto che si è tenuta recentemente a Fiuggi e che ha aperto una stagione di confronto con la controparte datoriale che non sarà facile in una fase di crisi dell’editoria come quella che stiamo attraversando; ed è inutile che io sottolinei come anche noi siamo interessati ad un buon risultato della stagione contrattuale
Si è concluso positivamente il confronto, che è durato per quasi dodici mesi, col governo, e per esso con il Ministero del Lavoro, sulla questione della sostenibilità a 50 anni del bilancio dell’Inpgi, come da richiesta del ministro Fornero, inizialmente formulata in tono quasi minaccioso al nostro Istituto e a tutte le Casse privatizzate. Si è arrivati, lo scorso 20 novembre, all’apprezzamento esplicito del governo per quanto fatto dalle Casse, e fra di esse dall’Inpgi, valendosi esclusivamente di risorse proprie (cioè dei contributi versati dagli iscritti e dalle aziende), per garantire nel tempo l’equilibrio fra entrate contributive e prestazioni previdenziali.
Tuttavia siamo anche consapevoli della necessità di mantenere la guardia alta, anche perché le “attenzioni” del governo sul nostro Istituto di previdenza non vengono meno.
In proposito, credo si possa dare per sventata la proposta, forse anche intempestivamente e troppo sommariamente comunicata, del ministro Andrea Riccardi, di utilizzare parte del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, previa vendita agli inquilini a prezzi inferiori al mercato, per dare una “scossa” al mercato stesso e contemporaneamente assicurare nuove entrate allo Stato grazie alla tassa di registro. Successivamente c’è stato un altro tentativo di inserire una norma del genere nel decreto sviluppo, anch’esso respinto con motivazioni della Ragioneria generale dello Stato che mi sembra utile riportare perché suonano a conferma delle buone ragioni che l’Istituto propone a difesa della propria autonomia e a tutela degli iscritti. Ha detto dunque la Ragioneria che la vendita “comporta minori entrate, con la possibilità di pregiudicare la sostenibilità delle prestazioni previdenziali istituzionali garantita anche dal patrimonio immobiliare”, e che una riduzione forzata dei rendimenti patrimoniali determinerebbe “effetti sulle condizioni di sostenibilità finanziaria certificati dai bilanci tecnici”. Parole che, di tanto in tanto, andrebbero ricordate ai ministri pro tempore.
Anche se su questo punto registriamo finora un successo, la sequenza cronologica dei fatti dimostra infatti la pervicace volontà del governo di occuparsi dell’Inpgi in modo, per così dire, non amichevole. Così, ora abbiamo una sentenza del Consiglio di Stato che, contraddicendo due precedenti sentenze del Tar, pretende di inserire il nostro ente previdenziale nell’elenco formulato dall’Istat delle pubbliche amministrazioni, cui vanno quindi applicate le misure varate dal governo per attuare i tagli della spending review. Naturalmente ci sarà un ricorso, anche alla Corte di giustizia europea se non dovesse bastare la Corte Costituzionale; ma intanto vorrei segnalare la schizofrenia del governo, che da una parte riconosce col ministro Fornero che le Casse sono “enti previdenziali di diritto privato”, e dunque ne ribadisce l’autonomia garantita dall’ordinamento, dall’altra, e appena un mese dopo, chiede e ottiene dal Consiglio di Stato una pronuncia che va nel senso opposto, definendo la privatizzazione “una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo”. Queste le contraddizioni dei “tecnici”, con i quali, dopo un anno di muro contro muro, si era arrivati a qualche risultato. Non sappiamo cosa possiamo attenderci dal prossimo governo.
Il Fondo di perequazione
Indubbiamente più incisiva è stata la nostra iniziativa che ha accompagnato l’insediamento e l’avvio del Comitato di gestione del Fondo di previdenza complementare. Credo di poter dire che la presenza dell’Unione pensionati nel Comitato, da noi sempre richiesta, è frutto anche di una Unione più unita, più incisiva, più propositiva e quindi più credibile. Non a caso la decisione è maturata poco dopo lo svolgimento del nostro Congresso straordinario.
Come sapete, nella sua prima riunione dopo le ferie la Giunta esecutiva della Fnsi ha nominato la propria componente del Comitato tecnico di gestione del Fondo, che ha lo scopo di tutelare le prestazioni previdenziali erogate dall’Inpgi ai giornalisti titolari di trattamenti pensionistici e ai superstiti titolari di pensioni di reversibilità. Il Comitato, che è presieduto dal presidente dell’Inpgi Camporese e composto per l’Inpgi dal vicepresidente Paolo Serventi Longhi e per la Fnsi dal sottoscritto e dal segretario generale aggiunto Giovanni Rossi, si è insediato il 30 ottobre scorso verificando che c’è la possibilità di un primo intervento perequativo, in quanto i fondi accumulati finora lo consentono in misura accettabile.
Ho già detto al congresso di giugno che la solidarietà fra di noi non può essere unidirezionale. Per il momento, con l’istituzione del Fondo e con la sua alimentazione essa si muove verso di noi pensionati, e ne siamo grati a tutti, ma io spero che possa arrivare presto il momento in cui sarà l’Ungp a restituire in termini di solidarietà qualcosa ai colleghi più colpiti dalla crisi, che è pesante. Questo in relazione al bilancio dell’Unione. Qualcosa di più concreto spero di poter dire al prossimo Consiglio nazionale che si riunirà nella primavera del 2013.
I nostri conti
Terzo punto parzialmente positivo: il bilancio dell’Unione. Sapete che la nostra palla al piede è costituita dalla difficoltà che hanno alcuni gruppi regionali a contribuire economicamente alla vita della nostra organizzazione. Nell’anno trascorso, da una parte abbiamo fatto dei risparmi, con tagli anche dolorosi, dall’altra alcuni nostri responsabili regionali hanno avviato colloqui con le Associazioni territoriali per porre il problema, e qualcosa si sta muovendo: cito i casi di Roma, del Trentino Alto Adige e della Campania. Spero che altri seguiranno.
Uno sguardo sulla crisi
L’evoluzione è purtroppo negativa. Nei dodici mesi trascorsi, alla crisi del lavoro e dell’occupazione dei giornalisti si è aggiunta una pesante crisi industriale nel settore editoriale, di cui si avvertivano già i sintomi negli anni precedenti, ma che ora si è manifestata pienamente. Certamente non la consideriamo un alibi per mettere la sordina alle vertenze o comprimere le richieste economiche, ma sappiamo che essa contribuisce a dipingere un quadro a tinte fosche per il presente e per l’immediato futuro. Una situazione che richiederà da parte del nostro sindacato attenzione alle priorità da perseguire nella trattativa contrattuale.
I dati sono allarmanti. Due settimane fa, in questa stessa sala, è stato presentato il Rapporto annuale sulla professione giornalistica in Italia curato da Pino Rea per la LSDI (che in questo caso non è allucinogeno ma la sigla di “Libertà di Stampa Diritto all’Informazione”). Titolo del rapporto: “La fabbrica dei giornalisti”. Qualcuno ha chiosato “Fabbrica delle illusioni”, perché sé è vero che, contrariamente a quanto avviene nella gran parte dei Paesi occidentali dove “la densità della professione giornalistica è in declino”, in Italia i giornalisti continuano ad aumentare di numero (103.000 iscritti all’Ordine, arrotondo; il doppio della Francia, il triplo degli Usa e del Regno Unito); è anche vero che solo il 45% di essi sono attivi nella professione, e solo uno su cinque ha un contratto di lavoro dipendente. I colleghi che il rapporto definisce “visibili” in quanto titolari di una posizione all’Inpgi sono sì in aumento (da 43.300 nel 2009 ad oltre 46 mila l’anno scorso), ma a crescere è solo l’area del lavoro autonomo e parasubordinato dove i redditi sono pari rispettivamente a un quinto ed oltre un sesto della media dei redditi dei dipendenti da aziende editoriali. L’approvazione, finalmente, della legge sull’equo compenso è certamente un passo avanti nella direzione della doverosa garanzia di un riconoscimento della dignità del lavoro dei precari, ma è ancora troppo poco.
Ora, se confrontiamo i dati che ho citato con quelli ancora più recenti del Censis sulla “dieta” informativa degli italiani, troveremo una conferma dell’allarme: è stabile (e molto elevato) il consumo di televisione e di radio; in aumento Internet e tutta l’informazione diversamente veicolata (web, cellulari, social network, smartphone, ecc., compresi i siti internet dei quotidiani che però presto saranno a pagamento); ma è in pauroso calo il consumo di carta stampata, con venti punti percentuali di lettori in meno in cinque anni, oggi al di sotto del 50% della popolazione, con cali ancor più consistenti fra i giovani.
Senza nulla togliere alla validità a quello che è stato definito “giornalismo fai-da-te”, rilevo che si sta riducendo l’area della fruizione dei media coperta e in qualche modo certificata dall’intervento professionale dei giornalisti, mentre quella del giornalista sta diventando sempre di più una professione precaria. Mi chiedo: è un bene?
La crisi industriale tocca aziende di grande tradizione editoriale – Mondadori, Rcs, Gruppo Espresso – e si traduce in stati di crisi, ridimensionamento delle redazioni, riduzioni di organico già effettuate o minacciate (Pino Rea documenta 3300 posti di lavoro persi in cinque anni nei tre gruppi editoriali citati). Le due più grandi associazioni regionali di stampa, la Lombarda e la Romana, hanno recentemente denunciato l’uso abnorme e distorto del ricorso agli stati di crisi (quasi sessanta aziende nel 2012, alcune per così dire “recidive”, e altri se ne annunciano), che ha finito per snaturare uno strumento legislativo, la legge 416 poi modificata, a suo tempo introdotta per affrontare e risolvere casi eccezionali e documentati. Ora, con la modifica della legge sulla previdenza, recepita dall’Inpgi, l’età pensionabile dei giornalisti è stata portata a 65 anni per gli uomini, e un allungamento dell’età lavorativa è previsto anche per le donne; ma la 416 manda in pensione tutti gli interessati a 58 anni. C’è uno “scalino” o uno “scalone” che va colmato.
La legge sulla diffamazione – il caso Sallusti
E’ l’ultimo argomento che affronto, anche qui senza pretese esaustive, che sarebbero fuori luogo visto il tanto che si è detto e scritto in proposito. Per contrastare l’obbrobrio legislativo che si stava perpetrando al Senato abbiamo partecipato alla mobilitazione del Sindacato e dell’Ordine professionale, che ha ottenuto un successo solo parziale, in quanto la legge è stata messa in un cassetto. Ma abbiamo tutti potuto verificare l’animosità verso di noi che anima una parte non piccola di un Parlamento che non passerà alla storia per eccellenza di dibattiti e capacità legislativa.
Sui temi deontologici abbiamo diritto di parola in quanto titolari del diritto di cittadinanza e di iscritti all’Ordine, ma credo che difficilmente potremo raggiungere una posizione comune in quanto Unione. Io, almeno, non ho questa ambizione. E oltretutto la diffamazione è un reato che va sanzionato, anche se recentemente ho letto che qualcuno è contrario. Osservo che la polemica ci ha portati lontano, ma non vorrei che dimenticassimo che il caso nasce da un episodio di cattivo, direi di pessimo giornalismo, di cui Sallusti non è stato peraltro il primo responsabile. Su di esso si sono poi addensati una serie di errori e di comportamenti abnormi, oltre ai mali endemici della giustizia, come la irragionevole durata di processi, di quel processo in particolare. Ma ha pesato anche l’arbitraria dosatura delle sanzioni quando la vittima di una diffamazione è un magistrato. In proposito il nostro Ordine professionale ha una casistica convincente.
Detto questo, l’arresto di un giornalista per un reato commesso nell’esercizio della sua professione è una somma ingiustizia, un’aberrazione giuridica che squalifica l’ordinamento che lo prevede, e che consente ogni tipo di minaccia e di intromissione della politica e dei cosiddetti “poteri forti” in un ambito di autonomia garantito dalla Costituzione a difesa della libertà di tutti. Invece di correggere questa vergogna che ci fa forse unici in Europa, nell’iter parlamentare è emersa la volontà non di garantire come si dovrebbe il tempestivo, congruo e veloce ristoro del danno subito dalla vittima di una diffamazione, ma la proterva e un po’ vigliacca volontà di vendetta e di intimidazione della casta contro i giornalisti.
Il sindacato si è mosso correttamente per difendere un principio e per ottenere attorno ad esso il massimo della solidarietà di organizzazioni politiche e sindacali e dell’opinione pubblica. Ma la vicenda ci richiama al senso di responsabilità per l’enorme potere che abbiamo in mano e per come lo usiamo. Abbiamo, tutti, il dovere di essere più credibili.


.png)