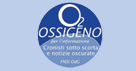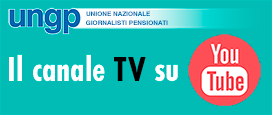12/06/2019
Il corso dell’Ungp sull’immigrazione: formazione di qualità
Gli interventi di Stefanella Campana e Paolo Baggiani
 Nato come corso di aggiornamento per giornalisti, l’incontro organizzato dall’Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati, coordinato dal presidente Guido Bossa, si è rivelato qualcosa in più di un appuntamento di fronte al quale limitarsi a mettere una firma per acquisire i relativi crediti. La titolazione intrigante, “Immigrazione, integrazione, informazione”, la caratura degli invitati, il modo con cui sono stati declinati temi che fanno parte del dibattito quotidiano ma che spesso vengono schiacciati su un chiacchiericcio indiscriminato, di fattura soprattutto televisiva, che non aiuta a capirne fino in fondo la portata e la drammaticità, ne hanno fatto un momento di qualità, per cui chi vi si è approcciato ha potuto portar via un bagaglio di conoscenze di prima mano, alcune dal sapore inedito.
Nato come corso di aggiornamento per giornalisti, l’incontro organizzato dall’Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati, coordinato dal presidente Guido Bossa, si è rivelato qualcosa in più di un appuntamento di fronte al quale limitarsi a mettere una firma per acquisire i relativi crediti. La titolazione intrigante, “Immigrazione, integrazione, informazione”, la caratura degli invitati, il modo con cui sono stati declinati temi che fanno parte del dibattito quotidiano ma che spesso vengono schiacciati su un chiacchiericcio indiscriminato, di fattura soprattutto televisiva, che non aiuta a capirne fino in fondo la portata e la drammaticità, ne hanno fatto un momento di qualità, per cui chi vi si è approcciato ha potuto portar via un bagaglio di conoscenze di prima mano, alcune dal sapore inedito.
Il corso si proponeva di fornire gli strumenti conoscitivi e di illustrare le problematiche legate al fenomeno migratorio e alla sua evoluzione nel tempo, nell’ottica del protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione.
Un punto di vista inevitabilmente “politico”, anche per l’eco che gli argomenti trattati hanno avuto nel determinare recenti scelte elettorali, è venuto dal prefetto Mario Morcone, attuale direttore del Consiglio italiano rifugiati, dopo essere stato, al culmine di una carriera prestigiosa, capo gabinetto del ministero dell’Interno con Minniti durante il governo Gentiloni. Un intervento, il suo, non privo di vis polemica anche nei confronti del ministro che ha sostituito Minniti, artefice di quel Dl sicurezza che Morcone, quasi scusandosi con i convenuti per la sua “passione” dialettica, si è divertito a scardinare quasi punto su punto. Morcone ne ha avute da dire anche ai mezzi d’informazione, “rei” di aver cavalcato una definizione come quella di “respingimenti indiretti” che a suo modo di vedere non ha ragione di esistere.
Appassionato anche l’intervento della giornalista italo-pakistana Sabika Shah, incentrato sull’attività dell’Associazione Carta di Roma, nata nel 2008. Shah è una delle maggiori promotrici dei diritti per le seconde generazioni e per i migranti in Italia. I suoi panel hanno posto in risalto gli obbrobri che vengono compiuti sui giornali e in tv quando si tocca l’argomento scottante dell’immigrazione. L’Associazione si occupa quotidianamente del monitoraggio della stampa su questi temi, tenendo sempre come riferimento il rispetto del codice deontologico, l’uso di termini giuridicamente appropriati, il rispetto del principio di verità sostanziale. Shah ha fornito l’elenco delle “parole chiave” sull’immigrazione usate come simbolo sui media a partire dal 2013: Lampedusa, Mare Nostrum, Europa, muri, Ong, per arrivare, nel 2018, a Salvini. Proprio nel 2018, paradossalmente, si è verificata una riduzione delle notizie sull’immigrazione rispetto agli anni precedenti. E si è esercitato un maggiore controllo sulla terminologia, come ha dimostrato a Macerata il caso di Pamela: per 334 volte nelle prime pagine dei quotidiani è stato utilizzato per i fatti di Macerata il termine “paura”, mentre sono stati sostanzialmente ignorati i termini “droga” e “spaccio” che invece facevano pienamente parte del contesto generale.
 Un rapido resoconto degli altri interventi: intriso di esperienza sul campo quello, via Skype, dell’inviato di “Avvenire” Nello Scavo. Il suo racconto sui campi profughi visti da dentro, malgrado certe difficoltà nel collegamento, ha preso tutti sul vivo. Stefanella Campana, dell’esecutivo Ungp, ha dedicato le sue attenzioni alle donne migranti, sottolineando che il fenomeno della migrazione femminile sussiste anche all’interno dei confini dell’Unione Europea. Paolo Baggiani, anche lui dell’esecutivo Ungp, in un intervento da lui stesso definito “controcorrente”, ha invitato a riflettere sulla differenza tra realtà effettiva e realtà percepita sul tema dell’immigrazione. Il paradosso sta nell’equazione: reati diminuiti, paura aumentata. Anche da Baggiani è arrivata una stoccata alla categoria di cui fa parte: i giornalisti stanno troppo dietro ai loro “wishful thinkings”, sposano troppo la versione della realtà che prediligono, e questo rende il loro racconto non abbastanza veritiero. Sul successo elettorale della Lega, ha detto, troppi giornalisti non hanno rappresentato correttamente la realtà, salvo doverne prendere atto dopo.
Un rapido resoconto degli altri interventi: intriso di esperienza sul campo quello, via Skype, dell’inviato di “Avvenire” Nello Scavo. Il suo racconto sui campi profughi visti da dentro, malgrado certe difficoltà nel collegamento, ha preso tutti sul vivo. Stefanella Campana, dell’esecutivo Ungp, ha dedicato le sue attenzioni alle donne migranti, sottolineando che il fenomeno della migrazione femminile sussiste anche all’interno dei confini dell’Unione Europea. Paolo Baggiani, anche lui dell’esecutivo Ungp, in un intervento da lui stesso definito “controcorrente”, ha invitato a riflettere sulla differenza tra realtà effettiva e realtà percepita sul tema dell’immigrazione. Il paradosso sta nell’equazione: reati diminuiti, paura aumentata. Anche da Baggiani è arrivata una stoccata alla categoria di cui fa parte: i giornalisti stanno troppo dietro ai loro “wishful thinkings”, sposano troppo la versione della realtà che prediligono, e questo rende il loro racconto non abbastanza veritiero. Sul successo elettorale della Lega, ha detto, troppi giornalisti non hanno rappresentato correttamente la realtà, salvo doverne prendere atto dopo.
In chiusura, l’intervento di Paolo Morozzo Della Rocca, esperto e responsabile legale dei corridoi umanitari della Comunità di San’Egidio. Una iniziativa, quella dei corridoi umanitari, il cui motore propulsore è stato la voglia di mettersi in azione dinanzi a tante morti nel mare Mediterraneo, verificatesi soprattutto a partire dal 2013, con il 2015 che si è rivelato un annus horribilis. E così si è pensato di creare una vera “politica dell’asilo”, consentendo a gruppi di migranti un viaggio legale e sicuro, non clandestino, e un arrivo in Italia con la legittimazione della protezione internazionale. Morozzo ha così chiosato il suo resoconto: l’accoglienza è “possibile”, e la società civile può giocarvi un ruolo primario.
Stefanella Campana: “Doppia discriminazione come donna e migrante”
 Nella complessità del fenomeno migratorio va approfondita la
realtà delle donne. Nel 2017 su 258 milioni di migranti nel mondo, metà erano
donne. Che cosa le spinge a lasciare il loro Paese, sapendo che vanno incontro
a una doppia discriminazione in quanto donne e migranti, spesso a rischi e
violenze, tra cui lo sfruttamento sessuale e la tratta? Nel 37% dei casi
(secondo l’OIM, l’organizzazione internazionale per le migrazioni) sono ragioni
connesse alla situazione familiare: violenze, abusi, matrimoni forzati e in età
precoce, mutilazioni genitali femminili (entro il 2030, fonte Unfpa-Onu, le
subiranno 68 milioni di donne). Ogni anno 15 milioni di bambine sono costrette
a sposarsi e 70 mila perdono la vita per parti precoci.
Nella complessità del fenomeno migratorio va approfondita la
realtà delle donne. Nel 2017 su 258 milioni di migranti nel mondo, metà erano
donne. Che cosa le spinge a lasciare il loro Paese, sapendo che vanno incontro
a una doppia discriminazione in quanto donne e migranti, spesso a rischi e
violenze, tra cui lo sfruttamento sessuale e la tratta? Nel 37% dei casi
(secondo l’OIM, l’organizzazione internazionale per le migrazioni) sono ragioni
connesse alla situazione familiare: violenze, abusi, matrimoni forzati e in età
precoce, mutilazioni genitali femminili (entro il 2030, fonte Unfpa-Onu, le
subiranno 68 milioni di donne). Ogni anno 15 milioni di bambine sono costrette
a sposarsi e 70 mila perdono la vita per parti precoci.
Partono da situazioni disagiate nei loro paesi d’origine: disuguaglianze e discriminazioni, scarso reddito, mancanza o scarso accesso all’istruzione e ai servizi sanitari. Se poi sono costrette a fuggire dalla propria terra perché in pericolo, da guerre o persecuzioni, la violenza diventa una costante. In Italia negli ultimi anni si è rilevata una presenza maggiore di donne sbarcate sulle nostre coste, la maggioranza di cittadinanza nigeriana, vittime nell’80% dei casi di tratta (dati OIM). Queste donne scappano dalle violenze nel loro paese, continuano a subirne durante il viaggio verso la Libia, dove una volta arrivate hanno buone possibilità di essere torturate e violentate. Se riescono a raggiungere l’Italia o l’Europa, continuano a essere a forte rischio di tratta. Organizzazioni internazionali hanno rilevato che nelle crisi umanitarie, nei campi rifugiati (Giordania, Siria, Libano) e centri di accoglienza crescono in modo esponenziale la violenza di genere sessuale e domestica, i matrimoni forzati e precoci, la prostituzione e la tratta (il 30% delle richiedenti asilo sarebbero indotte dalle stesse organizzazioni criminali).
 Di fronte a questa realtà le politiche di aiuto umanitario,
inclusa l’accoglienza, devono avere un approccio di genere tenendo anche conto
dei traumi fisici e psichici che queste donne subiscono. Già nel 2015 il
Rapporto del Parlamento europeo sulle donne richiedenti asilo e rifugiate
richiamava l’urgenza di definire linee guida “gender sensitive”, cioè rendere
le donne protagoniste della loro inclusione sociale. La Conferenza a Nairobi, prevista
dal 12 al 14 novembre 2019, sarà un richiamo alla comunità internazionale sull’accesso
universale delle donne alla pianificazione familiare e ai diritti sessuali e
riproduttivi, azzeramento mortalità materna per cause collegate al parto,
eliminazione violenza di genere, mutilazioni genitali femminili e matrimoni
precoci. Parlare di donne e immigrazione significa anche proporre uno sviluppo
sostenibile al mondo come sollecita l’Agenda 2030 sottoscritta nel 2015 dai
governi di 193 paesi membri dell’ONU, che ha indicato la parità di genere e
l’empowerment femminile come obiettivo specifico da raggiungere per l’intero
pianeta. Vale per tutte le donne, migranti comprese. Ma come combattere,
prevenire le discriminazioni multiple che le donne, le immigrate subiscono? In
aiuto la Convenzione del Consiglio d’Europa (nota come Convenzione di Istanbul)
su prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e violenza
domestica ratificata da Italia con la legge n. 77 del 2013. Si sofferma su
molestie sessuali, stupro, matrimonio forzato, delitti d’onore, mutilazioni
genitali femminili. Resta il problema della sua applicazione concreta.
Di fronte a questa realtà le politiche di aiuto umanitario,
inclusa l’accoglienza, devono avere un approccio di genere tenendo anche conto
dei traumi fisici e psichici che queste donne subiscono. Già nel 2015 il
Rapporto del Parlamento europeo sulle donne richiedenti asilo e rifugiate
richiamava l’urgenza di definire linee guida “gender sensitive”, cioè rendere
le donne protagoniste della loro inclusione sociale. La Conferenza a Nairobi, prevista
dal 12 al 14 novembre 2019, sarà un richiamo alla comunità internazionale sull’accesso
universale delle donne alla pianificazione familiare e ai diritti sessuali e
riproduttivi, azzeramento mortalità materna per cause collegate al parto,
eliminazione violenza di genere, mutilazioni genitali femminili e matrimoni
precoci. Parlare di donne e immigrazione significa anche proporre uno sviluppo
sostenibile al mondo come sollecita l’Agenda 2030 sottoscritta nel 2015 dai
governi di 193 paesi membri dell’ONU, che ha indicato la parità di genere e
l’empowerment femminile come obiettivo specifico da raggiungere per l’intero
pianeta. Vale per tutte le donne, migranti comprese. Ma come combattere,
prevenire le discriminazioni multiple che le donne, le immigrate subiscono? In
aiuto la Convenzione del Consiglio d’Europa (nota come Convenzione di Istanbul)
su prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e violenza
domestica ratificata da Italia con la legge n. 77 del 2013. Si sofferma su
molestie sessuali, stupro, matrimonio forzato, delitti d’onore, mutilazioni
genitali femminili. Resta il problema della sua applicazione concreta.
In Italia le immigrate rappresentano il 54% degli adulti stranieri, vale a dire l’8,6% della popolazione femminile totale. Il 58% di loro proviene da un paese europeo, un terzo ha la cittadinanza di un paese UE. Tra le extra-europee cresce il numero delle nubili, che rappresenta il 65%. Migrano sempre più da sole o per ricongiungimento familiare. Sono oltre 2 milioni le straniere regolari. Il tasso di occupazione delle immigrate è quasi uguale a quello delle italiane ma sono svantaggiate rispetto a una occupazione stabile e qualificata, nonostante molte abbiano titoli di studio elevato.
C’è un dato preoccupante su cui riflettere che vede protagoniste le giovani donne straniere della fascia di età 15-29 anni: il 44,3% è NEET, vale a dire che non lavora e non studia, percentuale che sale a 52,3% se si guarda al Sud. L’esclusione dal mondo del lavoro e della formazione viaggia in accordo con il modello patriarcale dei ruoli di genere che spesso costringono la donna a ruoli di cura domestica. Ruoli messi in discussione sempre più dalla crisi economica e dalla crescente disoccupazione. La penuria di lavoro porta anche un altro nuovo fenomeno: sono sempre di più gli uomini stranieri a formarsi in ambiti lavorativi tipici del mondo femminile, come quello della cura e assistenza alla persona.
Se la maggioranza delle immigrate si ritrova a lavorare in nero nei lavori di cura, va segnalato anche un dato positivo come la crescita dell’imprenditoria sostenuta da donne immigrate, il 23,1% di tutte le aziende guidate da lavoratori immigrati. E anche l’incremento dell’associazionismo per lo scambio interculturale, lotta alle discriminazioni, consulenza. Ma per quelle donne migranti lavoratrici che hanno meno tempo e possibilità di tessere reti amicali sul territorio esiste il rischio di un forte isolamento sociale e malessere psico-fisico.
Mentre in Italia il dibattito è più che mai aperto sulla sicurezza vale la pena ricordare che le donne straniere detenute sul totale dei detenuti stranieri sono il 4,5% (4,3% le italiane). In carcere sono in numero maggiore le romene (40% per reati contro patrimonio, 28% reati contro le persone), le nigeriane (25,7 reati contro le persone, 25,3 per stupefacenti, 14,5 prostituzione), a seguire quelle provenienti dalla Bosnia Erzegovina e Marocco.
Buone prassi
L’informazione dovrebbe essere scevra da pregiudizi e stereotipi anche nei confronti delle donne immigrate, come richiamano la Carta di Roma e la Carta di Venezia (sul tema specifico della violenza contro le donne). E dovrebbe anche considerare le esperienze positive. Un esempio è il programma RADICI, su RaiTre di Davide De Michelis, che racconta storie di integrazione riuscita di immigrati-e, senza dimenticare i legami con la cultura delle proprie origini. La realtà italiana presenta su tutto il territorio nazionale interessanti esperienze associative di aiuto e promozione (sostegno nei casi di violenza, progetti di formazione e alloggio). Luoghi di socializzazione e solidarietà. Ricordo due esperienze positive di Torino.
Il centro interculturale delle donne Alma Mater di Torino è nato nel 1993 con il sostegno del Comune, della Commissione Pari Opportunità della Regione (allora vi facevo parte), di molte associazioni femminili e di alcune donne delle organizzazioni sindacali. Un progetto ambizioso: ribaltare lo stereotipo del migrante come bisognoso, rivalutare e mettere in evidenza, grazie all’incontro multiculturale, le risorse, le capacità, i talenti individuali sovente invisibili e sommersi, di utilizzare queste competenze in progetti di cooperazione anche in campo economico. Di qui l’inserimento in lavori qualificati nelle banche, in centri informatici, corsi di riqualificazione rispetto ai lavori di cura, formazione per mediatrici culturali e anche l’apertura di un Hammam per le donne, il primo in Italia, un servizio per produrre reddito, come altre attività del Centro.
Un’iniziativa volta a far conoscere e valorizzare le donne migranti è il Concorso letterario nazionale Lingua Madre ideato da Daniela Finocchi nel 2005 e sostenuto dalla Regione Piemonte e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Offre spazio a tutte quelle narrazioni alternative, sguardi unici su realtà lontane e vicine attraverso gli occhi e la scrittura delle donne migranti che si rivelano “l’anello forte” delle diverse culture: un linguaggio rispettoso delle differenze e della differenza, banditi tutti i pregiudizi e luoghi comuni sulle/sugli immigrate/i e nessuna/o è autorizzata/o a pensare che una donna - per il solo fatto di non essere italiana – non sia istruita. Oltre 7000 le donne coinvolte sino ad oggi, che partecipano – scrivendo un racconto o inviando una fotografia – da sole, in coppia o in gruppo, a qualsiasi età, senza limiti o condizioni. Una sezione speciale è dedicata alle donne italiane che vogliano farsi tramite delle culture diverse, raccontando di donne straniere che hanno conosciuto e che hanno saputo trasmettere loro “altre” identità. Le opere selezionate vengono pubblicate in un libro e presentato al Salone internazionale del Libro di Torino. Ogni anno in tutta Italia Lingua Madre organizza oltre 100 incontri, convegni, laboratori, libri di approfondimento sui temi della migrazione femminile, spettacoli teatrali tratti dai racconti. Immaginari che assumono un’importanza fondamentale per metterci al riparo da distorsioni e pregiudizi. Compito questo che ci riguarda strettamente come giornalisti-e.
Stefanella Campana, Comitato esecutivo Ungp
Paolo Baggiani: L’informazione tra realtà effettiva e realtà percepita

“Ciò che dirò, rispetto agli interventi precedenti, potrà essere considerato controcorrente, ma ritengo opportuno esprimere alcune considerazioni sul fenomeno dell’immigrazione, proveniente per la maggior parte dai paesi africani e balcanici, che ha caratterizzato i recenti anni della vita politica italiana ed europea.
Le posizioni manifestate dai diversi partiti e dalle organizzazioni sociali possono essere riassunte in due poli opposti: da un lato l’apertura delle frontiere con la conseguente accoglienza di centinaia di migliaia di persone, dall’altro il blocco totale degli arrivi e il respingimento degli immigrati ai paesi di origine.
Vorremmo attenerci ai dati reali sul fenomeno, lasciando da parte posizioni ideologiche o religiose, ma semmai evidenziando le contraddizioni nate intorno al problema.
Esistono in partenza alcuni nodi che condizionano gli aspetti di questo fenomeno.
1 – Il Trattato di Dublino, che regolarizza l’accoglienza ed il diritto di asilo, trattato da rivedere per evitare che il peso e gli oneri maggiori ricadano solo su alcuni Paesi.
2 – Le leggi del mare che obbligano il soccorso ai naufraghi ed il loro sbarco nei porti “sicuri” più vicini. Da sottolineare che queste leggi si riferiscono a un periodo storico nel quale era obbligo assistere chi andava per mare per motivi di lavoro o di diporto o, in casi estremi, di guerra. Ma possono valere ancora per le migliaia di persone che in pratica mettono in atto comportamenti da suicidi?
3 – Il favoreggiamento dei “mercanti di carne umana”, organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione altrui.
4 – L’aumento di un certo tipo di criminalità legata al commercio delle droghe, alla prostituzione e ad atti di violenza.
5 – Il favoreggiamento dell’industria del falso, che può contare su una rete capillare di distribuzione, e che costa all’economia decine di miliardi all’anno con la perdita di posti di lavoro regolari.
6 – Il sovraffollamento delle carceri italiane, dove il 33% dei detenuti sono stranieri. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, su una popolazione carceraria di circa 39.000 persone, gli stranieri rappresentano il 33,8%.
7 – La mancanza di accordi complessivi con i paesi di provenienza degli immigrati per far loro scontare le pene nei paesi di origine.
8 – La provenienza di immigrati da paesi che non hanno situazioni tali da giustificare il diritto all’asilo.
9 – Le difficoltà di realizzare i decreti di espulsione a causa degli alti costi.
10 – Il grave rischio che tra la massa degli immigrati si nascondano terroristi e “foreign fighters”.
11 – Difficoltà di inserimento e integrazione legate a un generale basso stato di scolarità e alla mancanza di qualifiche lavorative. A ciò si aggiunge la difficolta per i provenienti dai paesi islamici (paesi confessionali nei quali la legge e la religione sono strettamente interconnesse tra loro) di adattarsi a vivere in uno stato laico nel quale vige, almeno in teoria, la separazione tra Stato e Chiesa. Ciò implica comportamenti e azioni spesso in contrasto con le leggi esistenti, particolarmente nei confronti delle nuove generazioni che vogliono adattarsi ai costumi occidentali.
12 – Direttive europee che in teoria ripartiscono gli immigrati tra diversi paesi, molti dei quali però rifiutano l’accoglienza.
13 – Interventi della Magistratura che talvolta contrastano con la volontà politica sul tema.
14 – Costi legati all’accoglienza: secondo i dati del DEF del 2017, i costi ammontavano a circa 4,2 miliardi.
 C’è chi afferma che i migranti sono necessari all’economia italiana, in quanto svolgerebbero lavori di pura manovalanza (vedi raccolte agricole nel sud) rifiutati dagli italiani stessi. I loro versamenti al sistema previdenziale sono ritenuti essenziali per l’economia. Questo aspetto riguarda però solo coloro in possesso del permesso di soggiorno. Ma si trascura il fatto che moltissimi immigrati svolgono lavoro in nero, sfuggendo così a qualunque controllo. Su questi temi, l’informazione in generale è molto carente.
C’è chi afferma che i migranti sono necessari all’economia italiana, in quanto svolgerebbero lavori di pura manovalanza (vedi raccolte agricole nel sud) rifiutati dagli italiani stessi. I loro versamenti al sistema previdenziale sono ritenuti essenziali per l’economia. Questo aspetto riguarda però solo coloro in possesso del permesso di soggiorno. Ma si trascura il fatto che moltissimi immigrati svolgono lavoro in nero, sfuggendo così a qualunque controllo. Su questi temi, l’informazione in generale è molto carente.
Le recenti elezioni europee hanno messo in evidenza come i comportamenti degli elettori siano stati in aperto contrasto sulle notizie riportate dalla stampa. Valgano ad esempio due situazioni, quella di Riace e quella di Lampedusa, descritte sui media come un esempio da seguire per l’accoglienza.
“Succede che a Riace - scrive Mattia Feltri sulla Stampa del 29 maggio - il sindaco Mimmo Lucano (ormai ex) non è riuscito a entrare in consiglio comunale poiché la sua lista è arrivata terza. Lui ha preso centoquaranta preferenze, il dieci per cento dei votanti, il sette degli aventi diritto. Il nuovo sindaco guida una lista civica colma di leghisti, e la Lega è il partito più votato in paese alle Europee. Eppure Mimmo Lucano è l’ideatore e l’artefice del modello Riace, elogiatissimo modello d'accoglienza degli immigrati in decine di reportage giornalistici e servizi televisivi e filippiche politiche, per cui Riace era una piccola Svizzera, linde botteghe artigiane, gerani ai davanzali, armonia multietnica, ecumenismo, sottofondo di arpe. E il modello sarà senz' altro un buon modello, per l'amor del cielo, ma mai una volta che in queste filippiche politiche e in questi servizi giornalistici si registrasse uno di Riace con il dito alzato a dire eh no, a me pare una gran boiata. Bizzarro vero? Questo modello - conclude Mattia Feltri - ci piace tanto, piace a chiunque, in tutta Italia e in tutta Europa, tranne che ai riacesi. E non ce n'eravamo accorti.”
Lo stesso quadro vale per Lampedusa, descritta sui media come esempio di accoglienza tanto da ventilare addirittura il conferimento all’isola del premio Nobel. Ma il voto ha invece smentito in pieno le notizie e le opinioni, con la vittoria della Lega.
Cosa vuol dire? A mio parere, molti cittadini sono contrari, per motivi diversi, all’immigrazione in generale, ma non lo affermano per il timore di essere tacciati di razzismo. Il loro voto, sia nelle consultazioni europee che nelle recenti amministrative, dimostra questa asserzione.
Ciò porta a pensare che i giornalisti, in generale, siano stati troppo dietro ai loro “wishful thinkings”, sposando troppo la versione della realtà che hanno prediletto, rendendo il loro racconto non abbastanza veritiero. Sul successo elettorale della Lega, ad esempio, troppi giornalisti non hanno rappresentato correttamente la realtà, salvo doverne prendere atto dopo. Recenti inchieste e sondaggi riportano che mentre i crimini sono in diminuzione, cresce la paura generale dei cittadini per la loro sicurezza. Esiste quindi un notevole differenza tra l’effettiva realtà e quella percepita.
Probabilmente è arrivato il momento di una seria autocritica da parte di quei molti colleghi che sul tema si lasciano influenzare da posizioni ideologiche e ignorano o “travestono” la realtà per motivi che niente hanno a che fare con la corretta informazione.
Alla collega Shah che lamenta il fatto che troppo spesso nelle notizie di cronaca si riporta l’etnia di chi compie gli atti, vorrei infine ricordare che nascondere, o mettere in secondo piano, l’etnia di chi compie atti violenti o reati in genere non modifica niente. Si può cambiare il nome della rosa, ma sempre rosa è e il suo profumo non cambia.
Paolo Baggiani, Comitato esecutivo Ungp


.png)